|
|

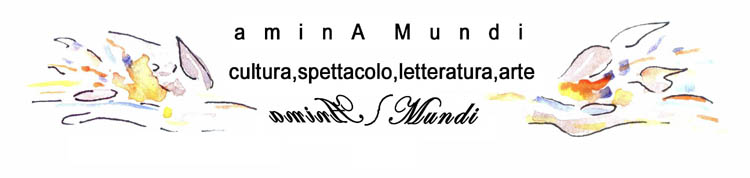 |
| Text/HTML
|
Riccardo Massa:
Il problematicismo pedagogico di Antonio Banfi e di Giovanni Maria Bertin
(stituzioni di pedagogia e scienze dell’educazione – editore Laterza)
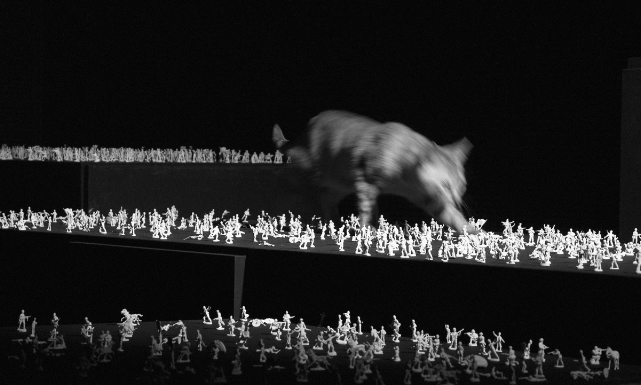
Nell’attività della filosofia italiana un contributo di notevole rilievo pedagogico è stato, tra le due guerre mondiali, quello di Antonio Banfi (1886-1957), le cui opere principali sono La Filosofia e la vita spirituale (1923), Principi di una teoria della ragione (1926) e L’uomo copernicano (1950).
I suoi scritti pedagogici principali, tra cui Le correnti della pedagogia contemporanea tedesca e il problema di una teoria filosofica dell’educazione (1925) sono stati ripubblicati con il titolo Pedagogia e filosofia dell’educazione. Banfi teorico del problematicismo, poi sviluppato con esiti di convergenza estremamente significativa tra razionalismo critico e marxismo, prende appunto le mosse da una salvaguardia della complessità, della problematicità, della concretezza e del rilievo culturale che ineriscono costitutivamente all’esperienza educativa e alla riflessione pedagogica, unitamente alla necessità di superare le determinazioni particolari di esse senza disperderle e annullarle. La cultura dell’idealismo di Fichte e dell’idealismo romantico nel suo insieme, come pure di ogni posizione neoidealistica, dello spirito. Occorre invece partire da una fenomenologia dell’educazione nel senso di un’analisi teoretica delle configurazioni storico-culturali in cui si realizzano gli ideali educativi (per Hegel la fenomenologia studiava la successione delle figure storiche e culturali attraverso cui si realizza dialetticamente l’autocoscienza, e per Husserl il termine sta invece a indicare il recupero dei significati più essenziali ed evidenti della realtà in quanto fenomeni di coscienza). Su quella strada Banfi giunge ad una distinzione fondamentale tra pedagogia e filosofia dell’educazione:
“l’idea di educazione non rappresenta così l’essere dell’educazione giacché l’educazione, in quanto è, è secondo mille forme e significati fenomenologici soggettivi e oggettivi, positivi e negativi, ed è nella loro tensione e irriducibilità stessa, tensione e irriducibilità che si manifestano universalmente alla coscienza, come la relazione tra ideale e reale, non mai riuscita nel campo educativo.
Il movimento fenomenologico della filosofia dell’educazione comporta dunque il riconoscimento della struttura universale della sfera educativa “non si tratta, si noti bene, di dedurre dalla pura idee dell’educazione gli aspetti oggettivi e concreti dell’educazione stessa, ma di concepire questi nell’unità delle relazioni trascendentali che caratterizzano il campo educativo e di cui l’idea è sintesi“ . E ancora “ le categorie dell’obiettività educativa costituiscono i concetti fondamentali di una pedagogia come sapere normativo, giacché una filosofia dell’educazione, come riconoscimento della struttura trascendentale del piano educativo, non esclude affatto una pedagogia normativa con intenti pratici”. In conclusione “ se la filosofia è la coscienza dell’universale struttura fenomenologica del campo educativo, questo non può raggiungere una determinazione teleologica, una soluzione della sua problematicità, se non nell’atto di una sintesi culturale, in una positiva e particolare valutazione, in una fede concreta e attiva”
E’ stato Giovanni Maria Bertin, professore emerito di Pedagogia all’Università di Bologna, a sviluppare, diffondere e approfondire, con particolare prestigio e autorevolezza, il problematicismo pedagogico in una compita filosofia dell’educazione riproponendo la distinzione banfiana tra pedagogia e filosofia dell’educazione come la sola capace di dare adeguata dignità culturale all’una e all’altra, oltre che di evitare una identificazione troppo generica della filosofia dell’educazione con l’intera filosofia in quanto tale. La sua opera principale, attenta anche alla dimensione etica, a quella estetica e a quella religiosa resta Educazione alla ragione (1968)
La Fenomenologia
L’altra grande filosofia trascendentale del nostro tempo, oltre alla persistenza di posizioni che si rifanno direttamente al criticismo neo-kantiano è costituita dalla fenomenologia di Edmund Husserl (1859-1938) le cui opere principali sono: Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia trascendentale (1913) e La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale (postuma). Il pensiero di Husserl ha influito profondamente sulla cultura contemporanea ed in particolare sull’esistenzialismo, sulla pedagogia, la psichiatria e le scienze umane in genere.
In pedagogia si sono rifatti ad Husserl ed al movimento fenomenologico nel suo complesso autori come R. Lochner, M.L. Langeveld e J. Dolch, sviluppando soprattutto le implicazioni metodologiche sul piano della ricerca educativa.
Anche nella filosofia dell’educazione attuale di lingua inglese e francese vi è grande attenzione per la fenomenologia, specie da parte di quelle pedagogie più impegnate politicamente per una critica radicale del cognitivismo didattico e dell’empirismo metodologico. Ma il contributo di gran lunga più importante per un ripensamento intorno alla cultura pedagogica della fenomenologia husserliana è stato quello offerto in Italia da Piero Bertolini con Fenomenologia e pedagogia (1958).
Ciò comunque che accomuna tutte queste linee di interpretazione filosofica dell’esperienza educativa è la non riducibilità di quest’ultima a un insieme di fatti.
Husserl ritiene appunto che occorra mettere fra parentesi l’esistenza medesima del mondo come qualcosa di indipendente dal rapporto di esso con la coscienza. E’ invece, soltanto se considerati all’interno di tale rapporto, chiamato intenzionalità che gli oggetti dell’esperienza svelano la propria essenza che è dunque possibile “tornare alle cose stesse” assumendo, in ordine ad esse, uno sguardo autenticamente disinteressato ed effettivamente capace di cogliere le diverse implicazioni di senso. Un tale procedimento, nei suoi vari movimenti, viene dunque chiamato da Husserl riduzione trascendentale . proprio nel senso di tendere a superare una considerazione puramente fattuale del mondo dell’uomo, com’è quella che ha posto in crisi le scienze europee e particolarmente la psicologia, per approdare invece alle loro forme pure, e soprattutto alle strutture della coscienza in quanto soggetto trascendentale e fondante. Qui Husserl inclina verso l’idealismo correggendo però un esito siffatto con la nozione di “mondo della vita”. Quest’ultimo sarebbe infatti quel complesso di esperienza precedenti a ogni astrazione scientifica che costituisce per la coscienza un dato originario e irriducibile.
Bertolini ha esercitato con successo l’applicazione fenomenologica in campo educativo, evidenziando suggestivamente l’importanza delle esperienze eccezionali e del linguaggio delle cose concrete per una dilatazione del campo esistenziale.
|
|
|
|