|
|

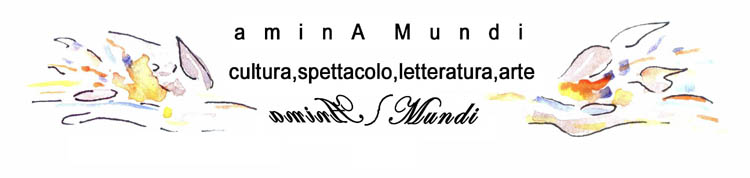 |
| Text/HTML
|
GIACOMO LEOPARDI - IN APPUNTO
Immensità s’annega il pensier mio:
E il naufragar m’è dolce in questo mare.

Simonide di Ceo e Giacomo Leopardi
autore Marcello Gigante
Nella dottrina di Leopardi, Simonide cantore dei morti alle Termopile rappresenta lo stesso autore satirico, giambico, elegiaco; la sua possente filologia depone le armi dinanzi alla varia grandezza del poeta di Ceo. Questo è l'avvio autentico finora negletto o deformato dell'itinerario simoniaco del Leopardi, che impone la lettura dei Canti XL e XLI, nel contesto più generale dell'incontro del poeta di Ceo e del poeta di Recanati.
Simonide, il vate della gloria che arride a chi lotta e muore per la patria si ritrova insieme al cantore dell'intensa brevità della vita soprattutto nella parola di Omero, maestro di verità.
L'intuizione del Leopardi, oggi è stata confermata, dai nuovi testi elegiaci rivelatici nel Papiro di Ossirinco 3965, edito da Peter Parrsons nel 1992 e spiegato da Martin West nel 1993; non solo riceve splendida conferma la rappresentazione aedica di Simonide ma apprendiamo anche che i distici dell'elegia, la cui traduzione in endecasillabi e settenari conclude i Canti, fanno parte di un'elegia più vasta di Simonide di Ceo in cui si svolge il motivo della caducità e dell'infelicità umana; la querelle sulla eternità dell'elegia è definitivamente terminata.
Questa è la gioia delle scoperte papiracee.
Insomma. i due Canti-traduzione non solo confermano la consonanza sentimentale dei due poeti, la medesima visione del mondo, il medesimo travaglio inventivo e espressivo, come mostrano le varianti autografe, ma segnano anche il ritorno di Leopardi a Simonide.
I due Canti finali sono stati correttamente posti sul medesimo piano della poesia A Silvia e di qualche Operetta morale, ma ricevono luce anche dalle pagine coeve dello Zibaldone.
In una lunga riflessione linguistica sui caratteri greci, il 4 giugno 1823, il poeta ricorda la traduzione secondo cui Simonide inventò i caratteri psi e omega. La celebre similitudine omerica (Iliade, VI 146) che Simonide cita nell'elegia tradotta dal Leopardi è presente anche nello Zibaldone.
In un passo dello Zibaldone datato 26-27 agosto 1823, il Leopardi si rifà ai versi del VI dell'Iliade, nei versi 146-149 Glauco dice a Diomede: "come stirpi di foglie così le stirpi degli uomini, (....) nasce una , l'altra dilegua". Sulla brevità della vita e la sua effimerità il Leopardi aveva riflettuto nello Zibaldone anche attraverso il celebre passo pindarico della Pitica VIII 136; "la vita è sogno di un'ombra", che egli citò secondo Jean-Jacques Barthélemy a proposito del dolore del nascere e della gioia del morire, sentimenti espressi da Sofocle e Bacchilide; "la vie, disoit Pindare, n'est que le rêve d'une ombre; image sublime, et qui d'un seul trait peint tout le néant de l'homme" (vedi G.Leopardi, Zibaldone dei pensieri, 2672 - 10.02.1823, p.1424 nell'edizione di G. Pacella) -.
Fu Stobeo a rivelare Simonide a Leopardi, che non mancò di esercitare sul testo del gnomòlogo il su talento di congetturatore. E' Stobeo a donargli la materia dei due Canti che chiudono il suo libro poetico. Il tema della brevità e della precarietà dell'umana vita aveva afferrato la sensibilità di Leopardi e si armonizzava al suo pessimismo, dopo essere stato il fondamento su cui si era edificato il "cuore cristiano" di Stobeo.
Nel 1823 - l'anno della traduzione dei due frammenti simonidei - il Leopardi trascrive nello Zibaldone un passo del Barthélemy:
"le plus grande des malheurs este de naître, le plus grand des bonheurs, e mourir"
(vedi G.Leopardi, Zibaldone dei pensieri, 2672 - volum. II, pag. 1424 nell'edizione di G. Pacella).
Strobeo rivelava a Leopardi attraverso vari apophthegmata (sul vizio, sulll'ingiustizia, sull'avidità, sul silenzio, sulla nobiltà di nascita, sulla ricchezza) e nel settembre 1823 Leopardi tradusse la Satira di Simonide sopra le donne che pubblicò nel novembre 1825 nel "Nuovo Ricoglitore" e poi nei Versi (Bologna 1826). Tale relativa rapidità di pubblicazione non arrise al volgarizzamento dei due frammenti simonidei eseguito fra altre traduzioni di brevi testi poetici antiche tra la seconda parte del 1823 e gli inizi del 1824. Infatti essi videro la luce la prima volta, nell'edizione napoletana dei Canti del 1835, presso Saverio Starita tra i Frammenti XXXVIII e XXXIX, accolse il tramonto della luna e la Ginestra ( utilizzata da Antonio Ranieri nell'edizione fiorentina del 1845) fu anticipata la stampa dei vv. 10-18 nel 1827, nello stesso anno in cui furono pubblicate per la prima volta le Operette morali scritte nel 1824.
E' una scelta conforme al pessimismo cosmico di quegli anni come hanno sostenuto sia Gilberto Lonardi sia Saverio Orlando che dopo aver tracciato, anche nell'orma di Emilio Bigi, l'itinerario di Leopardi traduttore, afferma forse troppo drasticamente che negli anni 1823-1824 Leopardi "non cercò più il bello, ma un credo morale". A mio parere, Leopardi mai disgiunse nella scelta la poesia dal pensiero. Questo aspetto unisce la poesia alla filosofia di Leopardi e si evidenzia anche nell'Operetta Parini, ovvero della gloria in cui compare Simonide, secondo il testo dell'edizione di Stobeo curata dal Gesner nel 1559.
L'Operetta prende il nome dal Parini, che ne è il protagonista ammirato e riverito all'inizio come uomo "di singolare innocenza di fede verso gli amici, di nobiltà d'animo e costanza contro le avversità della natura e della fortuna".
Il Leopardi, sotto la personalità del poeta settecentesco, sviluppa i suoi pensieri sul destino della gloria letteraria presso i contemporanei e i posteri. Il Parini così si rivolge "a un giovane d'indole e di ardore incredibile ai buoni studi e di espettazione maravigliosa" e lo istruisce, con ragionata pacatezza sulla difficoltà non solo di acquistare la gloria, ma anche di poterla godere. Il giovane mirava a conquistare la fama di egregio poeta o di scrittore ameno o di filosofo e il Parini, che veramente esprime con diverse parole qualche pensiero dello Zibaldone, gli dimostra che la poesia e la filosofia "le due sommità, per così dire, della arte ed ella scienza umana (...) sono in chi le professa, specialmente oggi , le facoltà più neglette del mondo" e che "il poeta e il filosofo non hanno in vita altro frutto del loro ingegno (...) se non forse una gloria nata e contenuta fra un piccolissimo numero di persone.".
A questo punto, e siamo così' al capitolo 10, il Parini esorta il giovane a godersi la gloria nella solitudine del suo animo e a farsene fondamento per nuove speranze.
Il giovane deve alla fine ricorrere con l'immaginazione "a quell'estremo rifugio" e "conforto degli animi grandi che è la posterità" si appoggia all'autorità di Cicerone, che non fece mistero della sua aspirazione,alla gloria dopo la morte e traduce il capitolo XXIII De senectute, dove "sotto altra persona" il grande oratore confessa di aver affrontato tante fatiche giorno e notte perché era convinto che la sua gloria andasse oltre i termini della sua vita; il suo animo "mirava di continuo alla posterità del mondo, come se egli, passato che fosse di vita, allora finalmente fosse per vivere".
Se Cicerone si riferiva a un sentimento dell'immortalità degli animi, il Parini-Leopardi ammette che la causa è "che tutti i beni del mondo non prima sono acquistati, che si conoscono indegni delle cure e delle fatiche avute in procacciarli" specialmente la gloria. E qui il Parini cita il detto di Simonide
La bella speme tutti ci nutrica
Di sembianze beate;
Onde ciascuno indarno si affatica;
Altri, l'aurora amica, altri l'estate
O la stagione aspetta;
E nullo in terra il mortale corso affretta
Cui nell'anno avvenir facili e piii
Con Pluto gli altri idii
La mente non prometta.
Il "Corriere delle Dame" che Carlo Leopardi definiva "il giornale più letterario che qui si abbia" nel numero 20 del 20 ottobre 1827 aveva pubblicato alcuni squarci delle Operette morali. E il 2 novembre 1827 da Recanati, Paolina scriveva al fratello, che era allora a Firenze: "ci struggiamo ancora, ed in modo crudele per la brama di sapere e di vedere cosa hai stampato, cosa stampa, e particolarmente quando vediamo nel Corriere delle Dame qualche tua parola, che noi crediamo presa dalle tue Operette morali"
(vedi G.Leopardi - Epistolario a.c. di F. Brioschi e P. Landi , Torino 1998 pag. 1157 vol II, p. 1399).
Le fonti poetiche di Semonide, senz' alcun dubbio autore del giambo, sono prima di tutto, Omero, specialmente l'Odissea. Esiodo e Archiloco.
Simonide anticipa motivi etici che troviamo poi sviluppati in Solone e Teognide. Sono ammonimenti, sentenze morali arcaiche che il poeta munito di sapienza e di esperienza rivolge ad un fanciullo.
Leopardi si ritrova nelle infinità delle sventure e delle pene e tuttavia rinnova e rifonda l'appello alla sapienza; un ammonimento a non amare ciò che è il nostro male, a non aspirarvi e a non affliggere l'animo con un'angoscia non necessaria.
Non do conto delle varie interpretazioni di passi particolari presso i classicisti perché un bilancio ermeneutico è stato tracciato anche dal Pellzer dopo grandi filologi come Reitzenstein o Hermann Fraenkel, ma veniamo alla interpretazione del Leopardi. Ecco quella che possiamo legger ancora oggi nelle Carte Leopardiane depositate nel tempio leopardiano della Biblioteca Nazionale di Napoli (X 1, 2a)
Simonide
(Stobeo)
Ogni mondano evento
e' di Giove in poter, di Giove, o figlio,
che giusta suo talento
ogni cosa dispone.
Ma di lunga stagione
nostro cieco pensier s'affanna e cura
benchè l'umana etate,
come destina il Ciel nostra ventura,
di giorno in giorno dura.
La bella speme tutti ci nutrica
di sembianze beate
Onde ciascuno indarno s'affatica.
E quale il mese e quale il di che amica
gli fia la sorte aspetta;
e nullo in terra vive
cui me l'anno avvenir facili e pii
con Pluto gli altri iddii
la mente non prometta.
Ecco pria che la speme in porto arrive
tal da vecchiezza è giunto
e tal da' morbi al nero Lete addutto;
questo è il rigido Marte e quello il flutto
del pelago rapisce; altri consunto
da l'egre cure, o tristo nodo al collo
circondando, sotterra si rifugge.
Così di mille mali
i miseri mortali
volgo fiero e diverso agita e strugge
ma se dal vano errore
mai si recasse a men distorta via,
patir non sosterria,
né fra tanto dolore
l'uomo al suo proprio ,al porrebbe amore.
In queste strofe libere di endecasillabi e settenari con varia ricercata rima -"un quid medium fra il canto disteso degli ultimi idilli e il recitativo della Ginestra" scrive il noto studioso Saverio Orlando, avvertiamo subito una nuova musica, una nuova forma,una trasposizione di immagini, una diversa trasfigurazione dei motivi.
L'Orlando ha rilevato giustamente che il frammento (X1, 2a) si intona alla "disperata ma vera filosofia del poeta" che trasforma l'invito di Simonide "a una realistica saggezza" nel "rimpianto della giovinezza e dei suoi dolci pensieri". Si tratta di una specie di esistenzialismo classico che fa fede alla vittoria della libertà cui anche l'arte mantica dà il suo contributo - (per approfondimenti: Saverio Orlando: Il pessimismo antico nel Leopardi traduttore, in studi in onore di A. Chiari - Brescia 1973).
Il processo di immedesimazione del Leopardi con Simonide ha la sua radice lontana nel 1818, quando scrisse la canzone all'Italia che inaugura la sua raccolta poetica. Tutti sanno che la seconda parte della prima lirica leopardiana è dominata da Simonide, che fu il grande celebratore della vittoria della Grecia sulla Persia, e il poeta recanatese non solo attinse da lui i motivi dell'immortalità dei morti nel celebre epigramma ma soprattutto, il motivo della gloria eterna dei vincitori alle Termopile. I versi sono noti e rappresentano il centro lirico della poesia. Questa fu la grande scoperta di Francesco De Sanctis, mentre al Carducci pareva che "il nocciolo lirico, anzi l'anima della Canzone" fosse rappresentato dai versi in cui Leopardi propone il suo patriottismo (36-40)
Nessun pugna per te? Non ti difende
Nessun de' tuoi? L'armi, qua l'armi; io solo
Combatterò, procomberò sol io.
Dammi, o cielo, che sia foco
Agl'italici petti il sangue mio.
A parte questo, il Carducci nel saggio del 1898 Le tre canzoni patriottiche di Giacomo Leopardi, vide chiaramente e polemicamente il ruolo di Simonide nella canzone all'Italia. L'anti-desanctisniano di Carducci affermò che era cosa nuova l'introduzione di Simonide nella poesia moderna fatta dal Leopardi e che l'anima della canzone all'Italia è "un Simonide-Leopardi, che vuol cantare e morire per la patria" - si può dunque concludere dicendo brevemente che il poeta di Recanati è un rinnovato Simonide che, interpreta il canto epico e lo rappresenta attraverso Homerus e le sue gesta eroiche.
(autore: Marcello Gigante - 1923-2001)
SarahFabriano in collaborazione Centro Studi Giacomo Leopardi - Catania,
Approfondimenti si possono trovare anche negli studi di Timpanaro e Robertis (vedi anche G.Leopardi, a cu di G. e D. Robertis , Milano 1987 - e - Timpanaro, La Filosofia di Giacomo Leopardi).
aminamundi 13 aprile 2014
----------------------
Marcello GIGANTE, Grecista italiano (Buccino 1923 - Napoli 2001); prof. universitario dal 1960, insegnò a Trieste ed a Napoli
Tra le opere ricordiamo: Nomos Basileus (1956); traduzione con note di commento delle Vite dei filosofi di Diogene Laerzio (1962); Teodoro Metochites. Ricerche filodemee (1969; 2a ed. 1983); Studi sulla civiltà letteraria bizantina (1981); Scetticismo ed epicureismo (1981). Inoltre ha pubblicato il Catalogo dei papiri ercolanesi (1979). È stato fondatore e direttore della rivista Cronache ercolanesi. Dopo la sua scomparsa sono apparse alcune raccolte di saggi e articoli come Il libro degli epigrammi di Filodemo (2002), Leopardi e l'antico (2003) e Scritti sulla poesia greca e latina (2006).
|
|
|
|