|
|

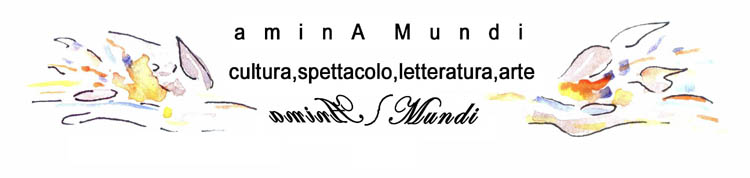 |
| Text/HTML
|
MI MANCA IL MARE
autore: Corrado Calabrò
 
Il poeta alla griglia
note di Miriam Binda
Riporto, dopo questo breve mio commento, uno stralcio del testo, tratto dalla seconda parte, del libro di Corrado Calabrò - Mi manca il mare (Edizioni Genesi, Torino 2013) nel quale l'autore, riferendosi al suo "sentirsi" intimamente poeta - analizza l'aspetto introspettivo, anche più spregiudicato di questo modo d'essere, nella civiltà che interagisce, in ambito letterario, con altri saperi. Inutile negarlo, la formazione attuale della struttura umanistica della conoscenza è contaminata (in senso positivo) dalla scienza e dall'informatica soprattutto per i mezzi di comunicazione - addomesticati all'uso quotidiano.
Il poeta di oggi, come ogni altra realtà vivente è circondato da uno spazio virtuale, non accidentale, in quanto rileva ed organizza posizioni e ruoli sempre più progrediti, per le giovani generazioni che si accostano alla conoscenza. Con arguta capacità d'analisi, Corrado Calabrò, mette a confronto la poesia con le tecno-parole della TV e della rete virtuale. Il saggio, riportato nella II parte del libro, s'intitola Il poeta alla griglia. Un titolo ironico per il doppio senso della griglia (=rete virtuale) al quale l'autore si riferisce, non a sproposito (non va dimenticato che Corrado Calabrò, per lungo tempo è stato Presidente AGCOM della Repubblica Italiana). L'ambientazione attuale, del poeta di oggi, secondo l'autore è una griglia. Questa griglia, a mio modo di vedere, fa venire in mente gli "arrosticini" che non si disprezzano soprattutto se si rimane in compagnia e vicino alla tavola disposta con buon vino. I poeti, come - gli "arrosticini" sulla griglia - cuociono nella rete virtuale, su questo reticolo incandescente, se non si cura la parola "va in fumo" e si disperde in un rivolo di fuliggine che non ha nulla di magico, al pari delle nebbie mitiche di Avalon” di Marion Zimmer Bradley. Sono troppo i discorsi e le parole veicolate dalla "logorrea" de-costruttiva per quei vasi comunicanti della cultura, di cui la poesia, è parte integrante se, ancora oggi, la si considera, virtù fatta ad arte per la parola; Mi manca il mare è un testo interessante e pigmentato da significati illuminanti che Corrado Calabrò, rivolge alla cifra del suo discorso, a titolo di testimonianza poetica capace di veicolare, l'attenzione del lettore, sulle ulteriori riflessioni acuminate col pensiero di Senofonte, Platone, Carandini, Heisenberg, Gadamer, Baldini, Oxana Pachlovska e altri filosofi o letterati contemporanei.
Mi manca il mare - è diviso in due sezioni - la prima parte - riporta le poesie - la seconda parte - invece è il saggio, di cui queste mie brevi note. Non ho commentato la prima parte - di poesie - perché sono come un cesto ricco di memorie sensuali, nelle notti d'ombra con l'urticante risveglio sul miele degli intimi ricordi: "quando ti svegli per il troppo silenzio in sudore e completamente ignorata, è allora che la notte fa paura" oppure "porta il broncio della sua stessa bellezza, fin da ieri sera il tuo volto di angelo di cera" questi versi non hanno bisogno di commentatori. Si rivolgono espressamente al lettore che li vuole ascoltare, annusare, condividere con pacata attenzione, fuori dalla ressa che a volte è arida solitudine dell'egocentrico interesse verso se stessi. La poesia, insiste il poeta, è anche gioia con la quale spiccare un volo "un colpo d'ala fin d'ove l'ossigeno ci manca".
Mi permetto invece, di lasciare un breve commento sulla II parte del libro - di Corrado Calabrò perché è una lezione che tranquillizza e consacra la poesia, ancora una volta, alla tradizione di quel "sentire" a me caro, e vivificato, come ha fatto l'autore, alla possibilità dell''esser-ci nel mondo (d'altronde Calabrò è uno studioso di Heidegger). Una condizione ontica che non nega, al poeta, la possibilità di elevare gli occhi al cielo per fare entrare quella semplice goccia d'eternità (irriducibile a qualsiasi mezzo estraneo al soggetto) capace di elevare la parola, all'infinita sua potenza - d'ordine e di creazione.
Occorre avere la misura per trattare - la creazione poetica - mi viene da chiudere, questo mio breve commento, sottraendo all'autore Corrado Calabrò, una sua frase che reputo illuminate:
"Esprimere l'indicibile è al tempo stesso impossibile e irrinunciabile, indispensabile, per qualche ragione che ci sfugge. La poesia, il bisogno dell'illimite, sono un po' come la massa mancante all'universo visibile; incombono sul nostro senso dell'esistere, ancorchè percepibili solo intuitivamente". (Mi manca il mare - Edizioni Genesi, Torino 2013, pag. 196)
(miriam luigia binda)
 ![csm_21_-_Correggio_01_cd345799bd[1].jpg](/Portals/0/csm_21_-_Correggio_01_cd345799bd[1].jpg) Correggio Giove e Io Correggio Giove e Io
A) Una rivista americana ha affermato recentemente che Platone e Aristotele non appartengono più alla cultura dell'uomo moderno. E altri (Andrea Carandini) ha parlato di natura anticlassica di questo nostro tempo. E' così?
Non c'è dubbio che la ragione abbia manifestato i suoi limiti come strumento cognitivo dela realtà. E che la realtà abbia manifestato la sua irragionevolezza. La meccanica quantistica delle particelle, col principio di identificazione di Heisenberg, col processo socastico, ha dimostrato che "Dio gioca a dadi" e che la natura si prende impertinentemente, gradi di libertà a dispetto degli illuministi Einstein e di ogni ragionamento sui massimi sistemi.
E' su questo gioco a dadi che si basa la nostra realtà elettronica, dal transistor ai cd (il linguaggio quantistico esprime ormai le leggi fondamentali della fisica, esclusa soltanto quella di gravità).
Addirittura la nostra incoercibile tendenza (da Socrate in poi) a razionalizzare, a normalizzare, ci spinge a cercare leggi costanti finanche dove l'informazione è irraggiungibile. Anche quando i singoli fenomeni sono ingovernabili e imprevedibili, la statistica, a livello di grandi numeri, ne può spedire la frequenza, persino per fenomeni caotici come il gioco, le guerre, le valanghe, i terremoti.
Uno degli aspetti moderni del caos è la logorrea della società contemporanea.Si chiede ormai così poco alla parola - ha osservato Giuseppe Pontiggia - che essa finisce quasi sempre per darlo. In TV le parole dello sprovveduto vale quanto quella dell'esperto; gli intervistati vengono sollecitati a pronunciarsi su quello che non sanno. La televisione apre si una finestra in diretta su qualsiasi parte del pianeta ma vuole telespettatori, recettori passivi che facciano audience, non operatori interattivi, anche se sta ben attenta a far credere il contrario (è per dare illusione dell'interattività, per far credere al telespettatore di entrare nel video, che la televisione fa tanti concorsi a premi?). La TV pialla il pensiero, gli toglie spessore. Il linguaggio viene usato dal potere (è il massimo potere oggi è quello dei mas media) per dominare comunicando, per appiattire le dismogeneità omologandole; dalla gente viene sperperato nelle chiacchiera universale.
Si può pensare che l'informatica consenta una certa riappropriazione del linguaggio da parte dell'individuo. Con l'informatica il ruolo di scrivere, dei giovani cambia velocemente; si avvicina di più al modo di parlare. Il che, tuttavia, si fa acquistare in spontaneità, non fa guadagnare in qualità. La riconversione della scrittura è all'immediatezza, allo spontaneismo dell'oralità, non alla pregnanza della parola consegnata alla tradizione orale. Si tratta di una comunicazione che resta generalmente a livello di conversazione e con essa scorre via torrenzialmente, senza fecondare il terreno, senza lasciare traccia nella psiche. Logorrea orale e scritta, dunque. Eppure in tanta sovrabbondanza, il bisogno della poesia nasce, paradossalmente da una carenza di linguaggio. In un mondo, in un'epoca logorroici, quando vogliamo dire qualcosa di assolutamente nostro, di nuovo, di vero, di non detto, forse l'indicibile, ci accorgiamo che ci mancano le parole. E già perchè per dire il suo personalissimo indicibile il poeta deve adoperare la parola, vale a dire il mezzo espressivo più usato; più sciupato, più abusato che ci sia. La faciloneria, il qualunquismo, lo scoraggiamento, conducono i più a chiedere troppo poco alla parola; come chi calci il pallone a casaccio e poi pretenda ch'entri nel sette. La sofisticazione intellettualistica induce i più esigenti a chiedere troppo, porta alla pantomima asfittica del non detto; ginnastica preparatoria di una partita che non sarà giocata. La poesia, praticata da milioni e milioni di persone, rischia di risolversi in vizio solitario.
Viviamo in tempi di pensiero debole, di destrutturazione della conoscenza.
Una grande caduta di forze scoraggia qualsiasi impennata dell'arte, della poesia.
Del resto a che servirebbero le forze, le ali, a tendere a che cosa, in un'epoca in cui viene assiomaticamente negata la sopravvivenza di valori, di aspirazioni che diano portanza alla creatività nella generale dissolvenza?
Il primo e massimo valore investito dallo scetticismo è la "verità".
Non si tratta solamente di sfiducia filosofica nella capacità umana di attingere "la cosa in sé", si tratta, anche e soprattutto, di indifferenza. La quale potrebbe fors'anche essere salutare se riferita solo alla verità nel senso occidentale e prevaricatore di verità posseduta (Wahrheit) e non facesse un tutt'uno di essa e della verità nel senso greco di rivelazione (ἀποκάλυψι).
Ma poiché natura non tolerat vacuum, il vuoto spinto così prodotto è stato riempito dall'ideologismo e dalla cultura dell'effimero, rassicuranti perché ci esentano da qualsiasi tensione al superamento, al di là, "la società vuole che gli artisti siano lassù in alto, sul podio, o in testa ai cortei, e in coda ai girotondi, in modo da rassicurarci che la letteratura non esiste, che la fantasia non esiste, e che l'immaginazione religiosa non ha alcuna importanza.
Su questa sostituzione di valenze aggreganti a valori esigenti, iil gruppo di intellettuali dominanti ha fatto leva per l'affermazione del proprio circuito di potere, ancorché preferiscono invece professare e far credere che la poesia si contrapponga semplicemente al potere politico e non anche al loro potere costitutivo (ben più compressivo della creatività artistica perché ne determina il riconoscimento o il conculcamento) . E' andato così smarrito il senso profondo dell'arte, della poesia; e con esso la capacità stessa di percepirlo. "Nell'occidente avanzato, a forza di logos (=giudizio, ciò che lega A a B) e di intelletto (=interlego), si è perso di vista il primigenio nous, che dice piuttosto annusare (come il cane di Ulisse, Argo che ha fiuto riconosce il padrone). Il verbo poetico, invece è un po' fatto di una fisicità che ti fa annusare il reale." (Oxona Pachlovska).
La poesia è stata relegata al mondo del divertimento intellettuale, del relax, del sollecito, dell'intrattenimento, del desiderio di apparire originali, all'avanguardia, alla moda; e la moda cambia ogni stagione.
In questa obliterazione dei valori dell'arte, della creatività, della poesia, un ruolo dominane (malgrado la contrapposizione di Jean Paul Aron) ha giocato la Francia, anzi Parigi, della cui cultura, la letteratura europea, è massimamente quella italiana, sono vassalle. Ci furono stagioni, anche esaltanti (ad es. l'impressionismo), in cui Parigi era la letteratura, la pittura, l'arte. Oggi essa è rimasta soprattutto la capitale della moda, identificata tout court con la perenne avanguardia di tutto quel che vale essere, anzi apparire.
Smarrita l'impressività, l'icasticità dei lirici greci, la poesia, l'arte vivono la vita effimera di una moda vorace che la consuma vorticosamente senza che ne resti traccia, come avviene dei giornali che appunto durano un giorno, e delle migliaia di notizie che scorrono ininterrottamente sul video dei nostri terminali. Le pseudo-poesie imperanti (per riconoscimento auto-referente, non per etero-lettura) sono come i giocattoli rotti dei bambini nevrotici, che li smontano perché vorrebbero essere loro a ricostruirli, a farli funzionare. Solo che non ne sono capaci e non vogliono ammetterlo (c'e' della magia anche nel montaggio) e allora dicono che il giocattolo non gli interessa che è dèmodé (parola terribile, condanna senz'appello). Assistiamo ad una versificazione che non trae alimento da una vera profondità (troppo isolata come i pozzi nel deserto, per fare proseliti, movimento culturale) ma dalla pre-letteratura e dall'ideologia.
Un'incapacità di rappresentazione propria che ha bisogno di essere mediata dalla rappresentazione altrui, non quale arricchimento della nostra capacità di esprimerci ma come omologazione della nostra identità. Come nella pittura bizantina, gli stilemi si susseguono nell'imitazione gli uni degli altri, depotenziandosi sempre più della capacità di raffigurazione diretta. Possono solo essere riprodotti, in forma omologata, i modelli e le maniere proposti. Un'esperienza mancata, una scelta ch'altri ha fatto per noi, un'informazione di seconda, terza, ennesima mano, passata attraverso innumerevoli filtri della cultura, sono gli alambicchi in fondo ai quali si rinviene al postutto, solo un'espressione residuale, inerte, deprivata della capacità di suscitare qualsiasi reazione, qualsiasi interazione.
L'opposto della poesia, ch'è scoperta che zampilla sempre nuova e gioia improvvisa di quella scoperta.
Contro la glaciazione della cultura (J.P.Aron) si dibatte, rappresa nel fondo del nostro voler essere noi stessi, una propensione inesprimibile all' ἀλήθεια (dischiudimento) o almeno all'autenticità. Sentiamo il bisogno della poesia come gli alpinisti sentono il bisogno di salire sempre in alto. Anche se in cima non si può sostare; la rarefazione dell'ossigeno ci riporta ben presto a quote più praticabili.
Il poeta scrive perché non può tacere "quello che non sa di dover dire". Ma come possono condividere questa spinta interiore certi signori della letteratura che non hanno mai conosciuto la condizione di entusiasmo sperimentata da chi ha sentito un dio entrare dentro di sé (Εγώ θεός), quella condizione di possessione della mente, di divina follia, di cui parla Platone e che corrisponde misteriosamente alla nostra attesa più profonda?
In quest'epoca di inautenticità dove va dunque a sbattere il povero poeta? "intanto lui stesso si è perso nella sterilità del mero intellettualismo dominate. Non ha più naso. Come nella figlia del Capitano di Puŝkin: Pugačov sente nella tormenta di neve l'odore del fumo dell'isba (...) l'uomo di città non sente nulla. La poesia di questo intellettualismo è sterile. Parla (quando non balbetta) al più alla testa. (Oxama Pachlovska)
Il presente testo - dalla lettera A) è tratto dal libro edito dell'autore
autore:
Corrado Calabrò - Mi manca il mare
Genesi Editrice, Torino - 2013 pag. 168-176
|
|
|
|