|
|

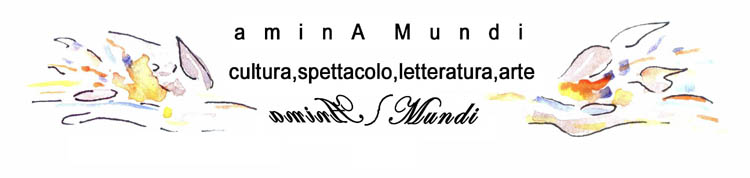 |
| Text/HTML
|
PERCY BYSSHE SHELLEY - IN APPUNTO
IN DIFESA DELLA POESIA DI PERCY BYSSHE SHELLEY
note: & riflessioni - di Miriam Luigia Binda

Amor aeternus
Ricchezze e lodi svaniscono nella massa
del ande mare umano del giusto e dell’ingiusto,
quando è la volta che il nostro possesso scada;
l’amore, anche se maldestro,
è tra le cose immortali,
che sano ogni fragile materia
che siamo, o siamo stati.
(Percy Bysshe Shelley)
Percy Bysshe Shelley (1792-1822) è un poeta romantico, filosofo e culture dell'arte classica, nato in Inghilterra ha vissuto molti anni anche in Italia.
Il faccendiere Thomas Love Peacock, amico del poeta, in nome dello scientismo pauperistico, attribuiva un vezzo pregiudizievole dell'inutilità sociale dell'arte poetica. Come fosse un involucro oramai logoro, secondo il sedicente faccendiere, occorreva disfarsi della poesia per restare al passo con i tempi moderni.
Shelley ha saputo difendere la poesia dagli attacchi ricevuti, attraverso un delicato discorso che ha successivamente raccolto e pubblicato nell'anno 1821, un anno prima la sua morte. In una nota del suo libro, paragona la rosa alla poesia. L'assimilazione "rosa-poesia" evoca la fragranza della rosa, anche quando scompare, la giovinezza, al declinare del tempo. Il luogo scelto per introdurre il suo saggio è dunque, un giardino; fresco, accogliente, un posto nel quale ci si può riposare con la meditazione. Si tratta di uno scenario romantico nel quale Shelley cerca di proteggere la poesia, dalla spregiudicatezza di coloro che la considerano inutile. A mio modo di vedere, l' interpretazione di Shelley, pone la poesia addirittura nell'eternità che sovrasta i sensi. In un connubio di fiori e parole la sinestesia di Shelley, profila la poetica nel tatto, nella musica e nel colore; ogni parola si sposa alla fragranza di una rosa, nel giardino del mondo.
Anche un neofita all'arte poetica può leggere questo bel libricino; in difesa della poesia. Il lettore può trovare le risposte alle domande che, in genere si chiedono ai poeti. La domanda più tradizionale: che cosa serve la poesia? Non a caso, Shelley scioglie la discussione a partire dal termine "immaginazione" secondi il quale l'atto stesso di immaginare non sacrifica la bellezza, alle turbolenze psichiche disorganizzate dal pensiero ma, al contrario lo eleva allo stato di gioia della mente ispirata. Non dobbiamo dimenticare che Shelley è un romantico per cui la partecipazione ontologica tra lo stato virtuale e materiale è sempre una benedizione dell'Altissimo. Qui di seguito, riporto una frase tratta dal suo libro "senza la poesia, la civiltà cristiana e cavalleresca, il mondo sarebbe caduto in uno stato di totale anarchia ed angosciosa tenebrosa" (pag.40).
Al centro di questo particolare interesse romantico troviamo la testimonianza di Byron che ha elevato la poesia alla filosofica della libertà attraversando percorsi folgoranti e carichi di drammaticità. Egli infatti, per i suoi eccessi di debiti e storie travolgenti, fu giudicato un dandy di fragile temperamento ma queste considerazioni sono superficiali se messe a confronto con la sensibilità d'animo connessa all'intelligenza della sua missione civile. Fu sorprendentemente solidale col popolo greco al punto tale da interagire, con tutta la sua anima, alla lotta per l'indipendenza. La spiccata generosità di Lord Byron, nei confronti del popolo greco, testimonia un'emancipazione della sua personalità non riducibile alla singolare rappresentazione di un dandy egocentrico; fu sepolto in Grecia a Missolungi, all'età di 36 anni, il suo nome riecheggia tutt'oggi come un eroe, un difensore della libertà, oltre ad essere riconosciuto poeta universale.
Anche Shelley, come Byron sente il bisogno di scuotere l'anima, di farsi coraggio per non finire sotto il peso di un malessere confuso dall'incomprensione e difende la poesia con uno spirito romantico travolgente. Nel suo libro risveglia dei punti memorabili tratti dai capolavori di Dante, San Bernardo, Platone, Mosè, Plutarco e altri sapienti.
La poesia, da questo punti di vista è una sfida storica, che non ha vincitori o perdenti poiché in ogni epoca, ci sarà qualcuno che cerca di negarla e qualcun'altro che la vuole rappresentare in nome della libertà del pensiero e della parola.
Lo scopo del suo piccolo capolavoro, come già ho anticipato era di contraddire l'amico Thomas Love Peacock il quale, nel 1820, informava Shelley, di avergli spedito la copia del suo saggio The Four Ages of Poetry, nel quale dimostrava l'inutilità della poesia. Per Shelley, la poesia non solo era utile ma ragionevole e, il suo impegno, a difesa della poesia, fece risonanza anche nelle epoche successive. Benedetto Croce, nel 1933, all'università di Oxford, tenne una conferenza che celebrava l'operetta di Shelley. Anche Ungaretti, in Brasile, in una lezione difendeva la cultura antica di Giambattista Vico traendo commenti dalle riflessioni di Shelley.
Molto spesso si sente dire che i poeti sono misantropi perché vivono in un mondo appartato. Secondo me sbagliano anche coloro che, oggi come oggi, cercano qualche particolare confronto tra chi è poeta (poco noto al pubblico) e coloro che hanno realizzato una poesia per comunicarla al pubblico anche in veste discografica. Ad esempio Bruce Springsteen o, per restare in Italia, De Andrè, Celentano, Franco Battiato, oppure il poeta per antonomasia, Bob Dylan. Certamente questi nomi, dell'universo musicale, hanno fatto della poesia un arte parallela molto spettacolare e redditizia, in grado di asfaltare tutte le strade commerciali del mondo. Ma, non bisogna giustificare la poesia soltanto in termini di numeri quantificabili in business; mi preme sottolineare, a partire dal discorso di Shelley, che la poesia è soprattutto un umanesimo capovolto alla propria interiorità. Non bisogna confondere il poeta come fosse un misantropo che vive fuori dal mondo o, al contrario, pensarlo come un mondano che fa tendenza al pari di una pop-star.
Personalmente, svolgo gran parte della mia attività, nel silenzio di una stanza, il mondo vive e celebra le emozioni in forma virtuale, la presenza dei vissuti è trasportata da una forza interiore ed evocativa. Non è immediatamente parola in grado di dare un significato compiuto. Prima di tutto è un'immagine che parla. Forse sono proprio le parole che si sottraggono alla categoria dei significati che stanno sulla linea di confine con l'abisso. Il luogo che non è un luogo ma, come molti studiosi della psiche hanno definito è l' archetipo. Viene da noi, in sogno, viene con evocazioni fantastiche e apre la porta all'infinito. E' forse, in noi, il giardino dei giusti - per dirla con Shelley - il luogo della rosa che si fa poesia?
Ma attenzione a non scadere sempre in un fatto eccezionale. Poiché è vero che le persone che si avvicinano all'arte poetica devono affrontare la fatica di sopportare questa scelta con la consapevolezza che buona parte della loro produzione sarà incompresa o considerata nullificante anche nelle epoche successive quella di Shelley. Sopravvive l'incomprensione. Anche gli artisti - i poeti specialmente non si sforzano di tracciare, con la propria voce, una comunicazione con le persone che spesso chiedono delle spiegazioni.
La chiusura, è quindi ambivalente. E' un errore. Un errore pensare che non ci sia spiegazione, soprattutto per la poesia. Purtroppo va anche detto che attualmente l'uso del linguaggio è aggressivo e strategico. Soprattutto nella pubblicità, lo studio delle parole è finalizzato alla persuasione, che sollecita le persone a comprare un prodotto oppure un'altro. L'essenza della poesia non ha bisogno di mascheramenti o barriere falsificatrici perché già in sé mantiene allegorie fuori dal comune che si adeguano al senso di coloro che vogliono sfiorarla, per questo non è possibile adoperarla per un'azione collettiva e strumentale. Ben venga la sua inutilità; di fatto non è utile, il suo modo di esprimersi può essere anche un vaticinare anche se di profetico non ha alcun contenuto; la poesia non è uno strumento di comunicazione comune a meno che, come ha fatto Shelley la si crea per provocare una critica di valore morale. Tale valore lo si ottiene con una solida struttura di conoscenze partecipate da un numero cospicuo di studiosi e pensatori che hanno capito il significato della poesia come elemento di libertà.
Quando affrontai, fuori dall'ordinario, la mia prima psicoanalisi, con fervore ed entusiasmo, al pari di quando affrontai i miei studi filosofici, notai durante le difficili fasi del mio percorso analitico, che mi veniva attribuito, dalle persone incuranti di questa pratica quasi naturalistica, di non sapere comunicare le ragioni del mio percorso. Io non volevo assumermi il compito di comunicare una scelta personale. In verità non sopportavo di parlare con le persone che non ritenevo preparate su tale argomento. Io in prima persona non ero preparata. In merito anche ai miei studi filosofici, in passato, mi capitò di dover affrontare alcune considerazioni - a mio parere - sconsiderate che attribuivano agli studi filosofici un valore esclusivamente estetico. Nell'ambito della poesia, come per gli studi filosofici e per la psicoanalisi, la mia diretta esperienza ha verificato che non ci sono delle risposte in grado di giustificare tali scelte. Essere preparati o meno è una condizione "auto-da-fé" che deriva dall' auto-affermazione di sé, nella società, nella vita collettiva e si trova in un percorso giusto, nella sfera dello spirito. Di fatto non ci sono rispose generali. Un filosofo ha quindi il diritto di essere e basta?
Per sua scelta e per un fatto che lo naturalizza alla causa del dovere morale? E la psicoanalisi come può giustificare la scelta del suo percorso analitico se, la sua consapevolezza non ha bisogno di giustificarsi? Che significato hanno le metafore che ricordano un vissuto che non è ricordato in realtà? Dove si trova la poesia di qua o di la del vissuto?
Quando cominciai a verificare gli effetti meravigliosi dell'empatia compresi che bisognava dare parola a quelle forme che a volte si trovano sopra-pensiero. Come quando giocano i bambini e non sanno neppure di giocare talmente sono presi dalle loro fantasie. E' una buona scuola per gli adulti perché anche attraverso i loro giochi è possibile cogliere una sorta di poesia, un linguaggio sublimato dei bambini che diventano attori del tragico mondo degli adulti. E' un atto spirituale dare la parola alle rappresentazioni dei bambini, così come dare merito a certi aspetti della natura che, nel piccolo habitat in cui si possono osservare, esprimono una sapienza millenaria fatta di gesti anche affettuosi tra animali che vivono vicino a noi, tra arbusti spontanei che crescono accanto ai fiori che abbiamo coltivato in quel giardino meraviglioso in cui è possibile trovare, la fragranza della rosa - descritta da Shelley.
La poesia a volte non ha bisogno di un pubblico presente. In genere si consuma a sorsi in una stanza poco frequentata. Inoltre, ho scoperto che esiste - la perennità dell'essere - come diceva San Tommaso alcuni valori sono universali. Si manifestano in maniera spontanea quando l'ambiente è rilassato e non è tormentato da forme invadenti di follia. Forme che cercano di distruggere senza pietà tutte le rappresentazioni pacifiche che derivano anche dall'avere un contatto buono con la propria mente.
Il web è una grande vetrina virtuale che mette in mostra centinaia di profili che spesso nascondono il desiderio di essere liberi, oppure di mistificare la propria identità. Non sempre si scoprono le reali situazioni di ognuno; i contatti determinati soprattutto con i social, quelli che ho potuto constatare, sono spesso originati da un desiderio di divertirsi oppure alcuni contatti cercano di acquisire un ruolo dominante soprattutto sul piano politico o delle critiche sociali. Esempio ci sono blog e profili web (nascosti da pseudonimi) che stanno di fatto sostituendo l'autorità di giornalisti qualificati che lavorano in quotidiani storici. Giovani ragazzi, cercano nella rete i contatti che più si avvicinano ai loro gusti, alle loro esigenze anche di socializzare fuori dalla solitudine che spesso, si consuma, nella stanza di casa. Non - a caso - il movimento 5 stelle, in ambito politico è nato da un blog che ha convogliato la voce di centinaia di giovani. Esistono blog anche per dare voce a cantanti che normalmente non si sentono neppure alle radio. I social, consentono di raccogliere, numeri impressionanti di contatti. Ognuno dei quali ha materiale da comunicare, o mostrare a titolo di fotografie, ricette, barzellette, brani musicali, poesie, opinioni politiche. Si possono anche modificare i propri dati per evitare di essere riconosciuti. Anche molti politici comunicano con il popolo della rete ma lo scambio è sempre riduttivo, non approfondito. Ho portato questo esempio della rete, perché la parola si è notevolmente trasformata con l'uso di tecnologie che di fatto ha sostituito la parlata con la parola scritta.
Le pratiche spirituali non sono morte anzi sopravvivono nonostante la semplificazione della rete; quando qualcosa di spirituale, si sta per compiere, l'invisibile ci circonda con le sue note creative, nella rete neuronale che vale ancora molto per noi stessi. Per la nostra sopravvivenza, per la nostra civiltà, per decifrare, ragionare, ricordare, soffrire, gioire. C'e' una parola per dire tutto questo?
L'esigente trasmutazione sollecita un mondo sconosciuto che di fatto giunge incomprensibile: a frazioni minime luminose e cangianti significati - insignificanti all'apparenza. Con un cuore aperto al dialogo, posso dire che bisogna dare spazio alla parola libera: grazie all'uso (a volte inutile) della parola si apprende il valore del silenzio che apre lo stato della meditazione. Come ci insegna Shelley, nel suo piccolo testo, la riconciliazione interminabile tra l'essere e il non essere - tra l'inconscio e la coscienza, esiste nella poesia o alchimia che trasforma in oro liquido le acque velenose che dalla morte si riversano nella vita.(pag. 56) E.... come sappiamo la vita è anche libertà di parola.
(miriam luigia binda) /maggio 2016
Si riporta qui di seguito uno stralcio dell'opera - 1) IN DIFESA DELLA POESIA di Percy Bysshe Shelley.
(....)
Gli sforzi di Lokce, Hume, Gibbon, Voltaire, Rousseau e dei loro discepoli, in favore dell'umanità oppressa, meritano la gratitudine del genere umano. Tuttavia è facile calcolare il grado di avanzamento morale ed intellettuale che ci sarebbe stato nel mondo se essi non fossero mai vissuti.
Per un secolo o due si sarebbero dette un po' di scemenze in più; si sarebbe forse bruciato , come eretico qualche altro uomo, donna o bambino e forse, in questo momento non staremmo qui ad esprimere la nostra mutua soddisfazione per l'abolizione dell'Inquisizione in Spagna.
Ma quale sarebbe stata la condizione morale del mondo senza Dante, un Petrarca, un Boccaccio, un Chaucer, uno Shakespeare, un Calderon, un Lord Bacone o un Milton è cosa inimmaginabile; senza Raffaello e Michelangelo, senza la traduzione della poesia ebraica, senza la rinascita degli studi di letteratura greca; se non ci fossero stati tramandati i monumenti della scultura antica, e se la poesia della religione degli antichi si fosse estinta insieme al suo impianto dottrinario. In assenza di questi stimoli la mente umana non sarebbe mai stata in grado di inventare le scienze fisiche; ne sarebbe stato possibile applicare alle aberrazione della società quel ragionamento analitico che si cerca ora di elevare al di sopra della stessa facoltà creativa ed inventiva.
Possediamo più conoscenze nel campo morale, politico e storico di quanto siamo in grado di mettere in pratica; le nostre conoscenze scientifiche ed economiche sono esorbitanti rispetto a quelle che sarebbero necessarie a garantire un'equa distribuzione della ricchezza; in questi sistemi di pensiero la poesia è sepolta sotto il cumulo di fatti e di processi computazionali. Non è che siano privi di conoscenze relative a ciò che moralmente; politicamente ed economicamente è buono e giusto in assoluto, o almeno a ciò che è più giusto e migliore di quanto gli uomini siano attualmente abituati a fare o a sopportare solo che permettiamo che l'Io-non-oso stia al servizio dell'io-vorrei: quello che ci manca:
è la facoltà creativa di immaginare quello che conosciamo; ci manca l'impulso generoso che attualizza ciò che immaginiamo; quello che ci manca è la poesia della vita. I nostri calcoli sono sfuggiti al nostro stesso pensiero; abbiamo mangiato più di quanto siamo in grado di digerire.
L'assenza della facoltà poetica ha fatto si che il culto di quelle scienze che hanno allargato i confini del dominio dell'uomo sulla realtà esterna, abbia man mano circoscritto quelli del mondo interiore, e l'uomo pur soggiogando gli elementi è rimasto schiavo.
/..../
Cosa sarebbe la virtù, l'amore, l'amicizia, il patriottismo, quale sarebbe lo scenario di questo bell'universo che abitiamo; quali sarebbero le consolazioni al di qua della tomba; e quali le aspirazioni al di là di essa; se la poesia non si levasse a portarci la luce ed il fuoco da quelle eterne regioni dove la facoltà computazionale dalle ali di gufo non osa mai spiccare il volo?
I più grandi poeti di oggi sono chiamati a testimoniare se non sia un errore affermare che le più belle composizioni poetiche sono frutto di studio e fatica. Il lavoro e l'indugio raccomandati dai critici possono essere giustamente intesi a significare niente più che un'attenta osservazione dei momenti ispirati, ed un artificiale riempimento dei vuoti d'ispirazione mediante l'inserimento di espressioni convenzionali; una necessità questa imposta solo dalla limitatezza della stessa facoltà poetica. Milton infatti concepì il Paradise Lost come un tutto, prima di realizzarlo in parti. Abbiamo anche la sua autorevole testimonianza circa la musa che "gli ha dettato il canto non premeditato". E questo basti a chi vorrebbe avallare le cinquantasei varianti del primo verso dell'Orlando Furioso. Le composizioni ottenute in tal modo stanno alla poesia come un mosaico alla pittura.
Quest'istinto ed intuizione, propri della facoltà poetica, sono ancora più evidenti nelle arti plastiche e pittoriche, un grande quadro o una grande statua crescono per il potere dell'artista, come un bambino nel ventre materno; è la stessa mente che dirige le mani durante l'esecuzione è incapace di spiegare a se stessa l'origine, le gradazioni, o i mezzi del processo.
La poesia fissa i momenti più belli e più lieti delle menti più belle e gioiose. Si annuncia con la presenza evanescente di pensieri e sensazioni che associate a volte a un luogo o una persona, a volte generate solo dalla nostra mente, giungono sempre inattese, per allontanarsi senza che le abbiamo congedate; indicibilmente dolci, e nobilitanti, al punto che anche il desiderio ed il rimpianto che lasciano sono intrisi di piacer, poiché essa partecipa alla natura del suo oggetto. E' come se nella nostra natura più propria penetrasse una natura più divina; ma i suoi passi sono come quelli di un vento del mare che l'arrivo della burrasca cancella ma di cui rimangono solo le orme, come sabbia raggrinzita sul fondo. Queste e consimili condizioni, sono esperite principalmente da quelli dotati di più delicata sensibilità, e di più robusta immaginazione; e lo stato d'animo che ne deriva è in lotta con ogni basso desiderio. L'entusiasmo della virtù, dell'amore, del patriottismo, dell'amicizia, è legato essenzialmente a queste emozioni, perdurando le quali,l'io si rivela per quello che è; un atomo rispetto l'universo. I poeti non solo sono soggetti a queste esperienze in quanto spiriti estremamente sensibili, essi sono anche in grado di conferire alle loro creazioni le evanescenti tonalità cromatiche di questo mondo etereo; una parola, un tratto nella rappresentazione di una scena o di un affetto, toccherà la corda incantata, ed in quelli che abbiano mai provato queste emozioni; l'assopita, fredda e sepolta immagine del passato si ridesterà al soffio vivificante. La poesia rende perciò immortale tutto ciò che di più bello e di più buono c'e nel mondo.
(....)
1) - Percy Bysshe Shelley - in difesa della poesia- Mimesis, Milano 2013.
|
|
|
|