|
|

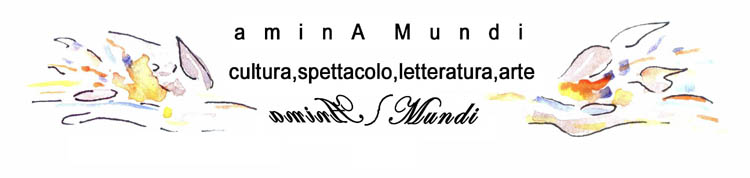 |
| Text/HTML
|
Karl Popper
La lezione di questo secolo
(intervista di Giancarlo Bosetti)
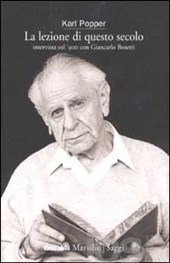
"la lezione di questo secolo" è una esortazione a renderci conto che è folle rischiare di compromettere il bene della pace nello Stato di diritto per cercare illusori paradisi che portano, come la storia ha dimostrato, alla guerra e alla tirannia.
E' tempo di abbandonare le critiche radicali al liberalismo e al mondo moderno per recuperare il senso della misura nelle valutazioni delle conquiste delle generazioni passate e nella ricerca delle vie migliori per difender la pace e la libertà.
(Maurizio Vitoli - Il Sole 24 ore)
Proponiamo la rilettura di questo opuscolo-libro di Karl Popper - La lezione di questo secolo - che riporta integralmente un'interessante intervista condotta da Giancarlo Bosetti. Un testo che rappresenta un approfondimento ulteriore, agli altri testi di Popper, per argomentare questioni che rientrano nella sfera quotidiana, a contatto con i giovani che rischiano di perdere il senso critico e civile sotto il peso di ideologiche che pesano ancora nel contesto culturale attuale. Per Popper, oltre alla capacità di razionalizzare le proprie responsabilità quotidiane, ogni persona che si definisce tale deve compiere lo sforzo di imparare qualcosa di nuovo e che faccia leva sulla propria libertà e non sulle ideologie del passato. Il cammino della consapevolezza è dunque un cammino generazionale di fondamentale importanza per tutta l'umanità. La storia non ha quindi il compito di insegnare il futuro ma di presentarci il passato per quello che è stato e che non è condizione di una ripetizione per il futuro prossimo. Non esiste infatti un futuro fondato sulla storia del passato. Senza il senso - dell'ottimismo - dice ancora Popper - non c'e' futuro per i giovani i quali, resterebbero intrappolati da quel genere di discorsi tendenzialmente deformati da ideologie "vittimizzanti" che riducono ogni condizione umana disagiata e senza via d'uscita per il prossimo futuro. Il senso dell'ottimismo intravisto e descritto da Popper - filosofo già ultra ottantenne - è invece un antidoto alla vittimizzazione in direzione di una visione del mondo altamente responsabilizzata anche dai fatti della storia che vengono compresi e non ripetuti.
Popper, come se potesse anticipare la realizzazione di una grande Europa ripulita dai sistemi nazionalistici e totalitari del passato, insiste quindi sulla nostra capacità di pensare ed intraprendere uno stile di vita - alleggerito dalle false informazioni che limitano la nostra libertà di pensiero.
15 dicembre 2014 (aminamundi - mb redazione)
di Giancarlo Bosetti - introduzione (estratto)
Ad un certo punto dell'intervista, verso la metà di una lunga seduta di lavoro nella sua casa di Kenley, un paese del Surrey a un'ora da Londra, mentre sta tornando ancora una volta sulla questione della sua critica centrale del marxismo, Karl Popper si alza dal tavolo, dove stiamo lavorando e mi invita a seguirlo nel salotto-libreria. Aggiriamo un grande pianoforte a coda, interamente coperto di libri, alcuni aperti. Altri libri, i più pesanti, sono collocati su leggii di metallo Guardo gli uno e gli altri, curioso di capire a che cosa stia lavorando (i filosofi presocratici, l'autobiografia del Dalai lama, la crisi dei missili a Cuba) ma Popper mi prende per un braccio e mi porta in fondo alla stanza, accanto agli scaffali che sono stati destinati a Marx, del quale sono qui riunite molte edizioni inglesi e tedesche dell'Ottocento, rilegate in pelle, i titoli a caratteri d'oro. E' la parte più vecchia di tutta la libreria, al capo opposto di quello dove, l'ottantanovenne filosofo tiene gli esemplari in tutte le lingue delle sue proprie opere. Mi mostra i tomi del Capitale su cui ha lavorato, fin da quando aveva diciassette anni. Ma non era questa la ragione per cui ci siamo alzati, perché ora va a scovare un volumetto più basso e smilzo. E' l'edizione inglese , del 1913, della Miseria della filosofia. Lo sfoglia, sapendo bene che cosa va cercando, e me lo mostra a pagina 117
"Vediamo che cosa dice qui". E legge una delle frasi conclusive del libro che Marx pubblicò a Parigi nel 1847 in polemica con La Filosofia della miseria che Proudhon aveva dato alle stampe un anno prima.
Si tratta del tema dell'affrancamento della classe oppressa" il proletariato, che "implica (...)necessariamente la creazione di una società nuova." il che avviene quando "i potenziali produttivi già acquisiti e i rapporti sociali esistenti non possono più esistere gli uni accanto agli altri". "L'organizzazione degli elementi rivoluzionari come classe presuppone l'esistenza di tutte le forze produttive che potevano generarsi in seno alla vecchia società".
Ma, di questo celebre passaggio, che introduce il concetto di "rivoluzione totale" e annuncia la fine di ogni antagonismo, Popper vuole rimarcare un punto preciso, come se vi vedesse il balenare di una smagliatura, come se li, nella testa di Marx, si affacciasse per un momento la domanda chiave, capace di i ribaltare l'intera costruzione torica. E legge queste tre righe:
"Vuol dire forse che dopo la caduta della vecchia società ci sarà una nuova dominazione di classe, che si sintetizzerà in un nuovo potere politico?"
L'interrogativo contiene probabilmente il nucleo essenziale del problema del comunismo, nel senso che proprio l'idea della fine di ogni conflitto sociale e politico si è rivelata incompatibile con la democrazia, con il principio della libertà di opposizione e quel che ne segue. Ma dopo quel punto di domanda Marx risponde semplicemente "No". "Ecco -dice Popper- lui sfiora con una domanda questo colossale problema. E poi che cosa fa? Dice "no", senza fornire alcuna spiegazione, senza neanche tentare, come qui avrebbe dovuto fare, di dimostrare perchè , di dimostrare su che cosa si regge questa sua previsione, così certa. Adesso sappiamo che questa risposta di Marx si è dimostrata falsa.
Popper è stato un grande avversario di Marx e del comunismo, di ogni pretesa di affermare un progetto politico sulla base della conoscenza delle leggi del divenire storico, è il teorico della società aperta e ha visto negli avvenimento del 1989 e del 1991 una conferma della validità delle sue principali critiche del marxismo. Quelle critiche aveva cominciato a formulare a diciassette anni, nel 1919, dopo una breve stagione in cui l'ideologia comunista - sull'onda soprattutto del pacifismo dei rivoluzionari bolscevichi - l'aveva sedotto, catturandolo anche lui nella "trappola per topi". Lo racconta in questa intervista, che arricchisce di elementi inediti e integra il resoconto di quella fase della sua vita già fornito nell'autobiografia. Quelle critiche avevano trovato la loro espressione compiuto in The Open Society and Its Enemies del 1945, che sarebbe uscito in italiano soltanto nel 1974 (La società aperta e i suoi nemici). Ma l'interesse di un incontro con le idee politiche di Popper, oggi, non sta solo nel ripercorrere i capisaldi del suo attacco al marxismo. Le ragione per cui sono qui con lui sono fondamentalmente due: una riguarda la storia, l'altra la teoria politica.
La prima è collegata alla domanda che fin dal 1989 avevo pensato di rivolgere ad un filosofo capace di concepire, poco dopo la rivoluzione d'ottobre, una critica del comunismo marxista in termini oggi condivisi nei punti essenziali, da quasi tutto il pensiero politico contemporaneo. Il regime comunista, nato nell'epoca della sua giovinezza è durato fin quasi ai suoi novant'anni, attraversando tutta la sua lunga vita. Volevo chiedere a Popper che aveva raggiunto così presto convinzioni molto chiare circa la natura dell'errore incarnato da quel regime, quale atteggiamento aveva assunto nel corso del tempo verso tanta gente, soprattutto verso gli intellettuali, rimasta ferma verso le convinzioni opposte. Mi chiedevo se la durata così lunga di un corso di cose che si reggeva su una teoria (lo storicismo marxista) di cui lui aveva individuato i dispositivi capaci di spiegarne sia la forza che l'errore, non l'avesse indotto in una sorta di fatalismo o di frustrazione. Insomma, a che cosa serve capire fino in fondo un errore, se poi l'errore viene ripetuto per così tanto tempo? Posto davanti a questa domanda, Popper non ha voluto affrontare direttamente la questione, se non in un punto, per ricavarne ancora una volta argomenti contro lo storicismo. In fondo, di lui qualcuno potrebbe pensare che è un uomo che ha aspettato sulla riva del fiume, in attesa che passassero i cadaveri dei suoi nemici. Ma nessun elemento di questa immagine si addice a Popper, nè i cadaveri, nè i nemici, nè soprattutto il fiume. Non i cadaveri, perché egli ritiene un fondamento della civilizzazione la non violenza. Non i nemici, perché la polarizzazione della storia e della politica tra amici e nemici è proprio una delle principali imputazione che rivolge al marxismo. E non il fiume, perché Popper ritiene questa rappresentazione delle storia, come un corso d'acqua del quale si conosce la sorgente e la foce, responsabile di un'enorme quantità di crimini. "il momento presente è quello in cui la storia finisce e noi non siamo affatto capaci di guardare nel futuro con l'idea di poterlo anticipare seguendo la corrente. così non possiamo neppure pensare l'ho sempre saputo che il fiume sarebbe passato di quà".
All'idea di società aperta corrisponde in Popper quella di avvenire aperto. dal passato molto si può imparare, ma nulla autorizza a proiettarlo sul futuro per anticiparne gli eventi. la pretesa di conoscere il corso del futuro dalla storia svuota il presente di responsabilità morale, trasforma gli uomini in esecutori di un "destino" che comunque si compirà.
Per il radicale antistoricismo di Popper l'idea stessa di un "senso della storia" di "una direzione del cammino delle vicende umane" è dunque una "pericolosa ideologia" perché conduce a legittimare la violenza, l'arbitrio, il peggio che sia dato agli uomini di subire. Si capisce allora perché rifiuti di porsi nelle condizioni di un uomo che dice - lo sapevo che sarebbe finita cosi'. Non si tratta di una esibizione di modestia, di un imbarazzo di circostanza. Popper, in verità è sinceramente soddisfatto del collasso comunista. Si tratta invece del fatto che per lui la convinzione di cavalcare l'onda della storia è da combattere comunque si presenti, in ogni manifestazione umana, persino nell'arte, non solo nella politica.
Se il marxismo era portatore della fiducia nel comunismo come movimento reale che abolisce lo stato presente di cose sulla base della conoscenza di "leggi" del divenire, sulla base di una teleologia che autorizza a plasmare la materia sociale, questo non legittima una convinzione opposta e speculare: la fine del comunismo non è l'esecuzione di altre "vere" leggi della storia. A sostengo di questa considerazione che potremmo definire anti-necessitaria oltre che antistoricistica. Popper fa dunque l'intervista che dura due settimane, meritevoli di essere meditate.
Estratto intervista a Karl Popper a cura di G. Bosetti
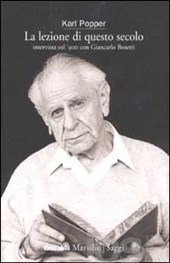 Giancarlo Bosetti - domanda a Popper: Giancarlo Bosetti - domanda a Popper:
Credo che questa intervista dovrebbe cominciare dal punto essenziale: la critica a Marx, che ha preso forma compiuto nel suo libro politico più importante - La società aperta e i suoi nemici. Saprebbe spiegarci come e quando Lei ha concepito l'elemento centrale di questa critica, come e quando si è convinto della necessità di quell'attacco alle "false profezie", da Platone a Marx, passando per Hegel che ha organizzato in maniera sistematica nel libro del 1945.
Popper: - risposta:
questa domanda mi porta molto indietro nel tempo, fino al luglio del 1919, quando non avevo ancora diciassette anni. Non giunsi, naturalmente così presto alla posizione che ho sostenuto, poi, con La società aperta e i suoi nemici, ma fu prima del mio diciassettesimo compleanno, proprio nel luglio del 1919, che decisi di rivedere il mio atteggiamento verso il marxismo, formulando l'idea che fosse necessario criticarlo. E raggiunsi, poco dopo. nel febbraio del 1920, nei suoi elementi essenziali, la posizione che ho sviluppato lungo tutto la mia vita. per cui vede, si tratta di molto tempo fa. E' c'e' ben poca gente, oggi, si può dire, in grado di ricordarsi i fatti di qui giorni. Era il periodo che seguiva, da poco la fine della prima guerra mondiale.
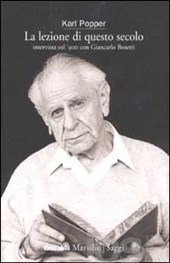 Giancarlo Bosetti: - domanda : Giancarlo Bosetti: - domanda :
quale era stata la sua posizione nei confronti della guerra?
Popper - risposta:
ero stato un pacifista, praticamente ancora bambino, prima che la guerra scoppiasse. i miei genitori erano pacifisti, mio padre aveva nella libreria testi contro la guerra, perchè era stato un deciso oppositore del militarismo austriaco. Quando la guerra divampò, io ero impaurito e allarmato per il fatto che molte persone del mio ambiente, amici della mia famiglia, facevano una svolta di 180 gradi e diventarono sostenitori della guerra. Mio padre mi spedì per il giorno del mio compleanno una lettera da Vienna (noi eravamo in vacanza) in cui spiegava che non poteva venire a trovarci, perché"purtroppo - così diceva - c'e' la guerra". La lettera era stata scritta - e questo è il fatto abbastanza strano - il giorno prima del mio compleanno, mentre la guerra scoppiò soltanto - mi pare proprio che le cose andarono così - il giorno esatto del compleanno. Questo vuol dire che lui dava per certo, con alcune ore di anticipo, che la guerra stava cominciando. Poco dopo tornai a Vienna, dove, nella mia scuola tutti erano sostenitori della guerra.
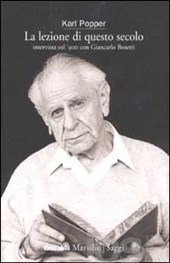 Giancarlo Bosetti - domanda: Giancarlo Bosetti - domanda:
una delle cause più gravi di violenza e di guerra sembra essere ora il nazionalismo. lei come guarda alle aspirazioni crescenti a dar luogo a stati indipendenti, anche in Europa? Ci vede di più un pericolo di regressione nella civilizzazione e di guerra o un diritto di popoli omogenei, per lingua, religione ad avere il proprio Stato?
Popper - risposta:
la questione essenziale è che in un mondo così densamente popolato tutti questi problemi sollevati dai nazionalismi - che, certo, vanno valutati nella loro complessità in ogni singolo caso - devono esser e considerati pericolosi. Si tratta di un pericolo che riguarda lo Stato di diritto. Bisogna dire che prima di tutto una cosa che, a quanto mi risulta, non viene considerata a sufficienza nel dibattito europeo sulle nazionalità, e che da sola contiene l'intera questione politica delle nazionalità; si tratta del fatto che le minoranze devono essere protette. La stessa idea di Stato-nazione è impossibile da realizzare se non si accetta prima di tutto quel principio. E quanto è vero a cominciare dal fatto che l'Europa è il risultato di immigrazioni accidentali dall'Asia. L'Europa è una penisola dell'Asia verso la quale diversi popoli sono stati spinti da varie vicende; quando hanno raggiunto l'Atlantico si sono divisi e i singoli gruppi si sono poi mescolati con il risultato che a parte la Germania, non c'e' paese senza le sue minoranze. per questo il punto fondamentale rimane la loro protezione. Questa è la posizione dalla quale si deve affrontare la questione Non possiamo pensare che tutte le minoranze possano costituire ciascuna il proprio Stato. Bisogna predisporre politiche di protezione, che soddisfino le esigenze delle minoranze, in special modo per quanto riguarda l'educazione, la lingua e la religione.
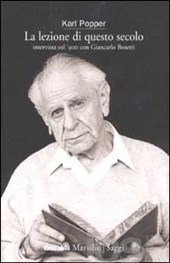 Giancarlo Bosetti - domanda: Giancarlo Bosetti - domanda:
bisogna convenire che chi dice "l'ho sempre saputo che finiva così" è un genere di persona molto sgradevole. Mi sono chiesto però, leggendo la sua autobiografia, e anche all'inizio di questa intervista, mentre raccontava del suo incontro con i fratelli Eisler a diciassette anni che effetto fa vedere che tante cose danno ragione alle sue critiche di tanto tempo fa. Lei ha formulato una critica radicale del comunismo ancora praticamente ragazzo. Per decenni avrà pensato: io ho ragione, prima o poi se ne accorgeranno tutti. Adesso, in questi mesi, non le è venuta voglia di dire "l'ho sempre saputo che il fiume sarebbe passato di qua?".
Popper - risposta:
sono contento che le cose siano andate così, ma non mi sento felice, ora, per il fatto di aver saputo per tutto il tempo dov'era l'errore. Questo non è niente. Da questo momento, dobbiamo guardare, a quello che si deve fare, alla cosa migliore che possiamo fare, al dovere che abbiamo da compiere. Qualunque cosa sia accaduta è passata. E dal passato noi possiamo imparare, certamente, ma non proiettarlo per anticipare il futuro. Questo ha a che fare anche con il tremendo declino dell'arte. Voglio dire che chiunque abbia visto le grandi opere del passato, per esempio quelle di Michelangelo, deve ammettere che vi è un declino dell'arte. Ovviamente Michelangelo è stato e resterà il più grande, e non possiamo aspettarci nulla del genere. Ma in ogni caso un declino c'e'. Perché? Perché tutti gli artisti si guardano intorno e tentano di diventare leader del futuro. Ascoltano, per cosi' dire gli storicisti che dicono cosa accadrà nel futuro, e cercano di mettersi nella corrente invece di pensare a fare opere di valore nel momento presente. Sono, prima, di tutto, molto interessati a se stessi piuttosto che alla qualità del loro lavoro, e inoltre, danno retta a cattivi profeti, a cattivi filosofi i quali a loro volta, cercano di precorrere i tempi futuri. Il fatto è che tutti cercano di stare là avanti al proprio tempo, ma nessuno può anticipare il futuro perché nessuno lo consce. Guardi Marx, per esempio: credeva appunto che tutte le macchine avrebbero avuto per sempre motori a vapore, e che tutti i motori sarebbero diventati sempre più grandi. Qualcosa di simile al mio rasoio elettrico era per lui impossibile da prevedere. A quanto pare abbiamo macchine e motori che diventano sempre più piccoli, invece che più grandi, e per il nostro uso personale. Marx vedeva la storia in termini di mezzi di produzione. In realtà la storia, in rapporto alle cose materiale, ha prodotto sviluppi in termini di beni di consumo. la grande rivoluzione di cui Marx non ha mai colto la portata è stata la rivoluzione ferroviaria, che ha consentito alla gente di diventare più mobile. E le ferrovie non sono state costruite nell'interesse della produzione, infatti le prime non servirono per il trasporto di merci ma, per il trasporto di persone. Si chiamavano "coaches" (carrozze) e in questo paese le chiamano ancora così, da quando venivano trainate dai cavalli, poi sostituiti dai motori a vapore che consentivano di formare convogli di tante carrozze e di rendere meno costoso il viaggio. Era un servizio per persone che andavano a trovare altre persone, a visitare altre città. Capisce che cosa voglio dire? un servizio personale, che ha rappresentato una delle più grandi rivoluzioni mai avvenute. Ma Marx non l'ha vista in quanto rivoluzione. Questo processo è stato poi sviluppato ulteriormente dalla rivoluzione fordista. Dall'iniziativa di Henry Ford che ha costruito automobili accessibili ai lavoratori, non solo ai miliardari. Parlo di queste cose perché si tratta di grandi rivoluzioni che nessuno può prevedere. Certamente non furono per nulla previste da Marx. Così ora nessuno può prevedere quale sarà la prossima grande invenzione in termini di servizio alle persone. Una di queste è stata la televisione, che è davvero diventata un grande orrore, anche se avrebbe potuto essere una benedizione.
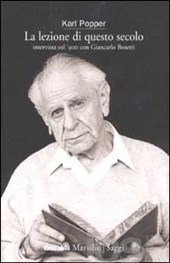 Giancarlo Bosetti - domanda Giancarlo Bosetti - domanda
lei davvero non la uò sopportare la televisione?
Popper - risposta:
no e, incidentalmente, le dirò che non ce l'ho e non la voglio in casa.
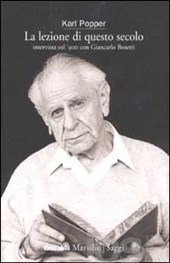 Giancalo Bosetti domanda Giancalo Bosetti domanda
a questa corsa attraverso le rivoluzioni tecnologiche siamo arrivati per dire che la pretesa storicista di conoscere il corso del fiume è infondata?
Popper risposta:
e' semplicemente un'idiozia, perché è un tentativo di prevedere il futuro della storia., mentre il punto vero della storia è che ci mette sempre davanti a una rivoluzione imprevedibile, come quella elettronica.
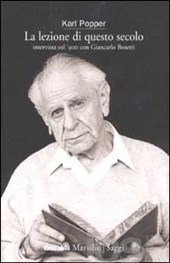 Giancarlo Bosetti - domanda Giancarlo Bosetti - domanda
ma porsi il problema del senso della storia, che potremmo anche chiamare della filosofia della storia è qualcosa di molto umano. Se possiamo interrogarci, con qualche pretesa scientifica sul problema delle dimensioni dell'universo, perché non possiamo anche chiederci quale è il senso della storia, se essa si muove in qualche direzione riconoscibile?
Popper risposta:
credo che questo sia un errore intellettuale. Non abbiamo bisogno di un senso della storia. Noi possiamo ammirare la storia; infatti è piena di cose che meritano di essere ammirate, di persone meravigliose. E possiamo anche imparare dalla storia ciò di cui dobbiamo aver paura. E tra le cose di cui dobbiamo aver paure c'e quello che lei chiama "senso della storia". Perché ci porta sempre e soltanto nella direzione sbagliata.
La speranza della gioventù:
Le nostre democrazie occidentali - innanzitutto gli Stati Uniti, la più antica delle democrazie occidentali - costituiscono un successo senza precedenti; un successo frutto di molto lavoro, di molti sforzi, di molta buona volontà e più che altro di molte idee creative in vari campi. Il risultato è che una maggior quantità di uomini felici vive una vita più libera, più bella, e più lunga di quanto sia mai avvenuto prima d'ora. So naturalmente che molte cose dovrebbero essere migliorate.
La più importante è certamente che le nostre "democrazie" non sono abbastanza chiaramente distinguibili dalle dittature della maggioranza. ma nella storia non vi sono mai stati prima d'ora Stati in cui gli uomini hanno potuto viver così liberamente e in cui hanno potuto avere una vita altrettanto buona, o migliore di questa.
So che troppo pochi uomini condividono quest'opinione. So che nel nostro mondo non mancano aspetti negativi: delinquenza, crudeltà, droga. Facciamo molti errori, e anche se molti di noi imparano dai loro errori alcuni vi rimangono imprigionati. Il mondo ci impone dei compiti. Possiamo vivere anche soddisfatti e felici, ma questo lo si deve anche dire!
Non lo sento dire quasi mai. Invece sento tutti i giorni lamentele e brontolii sul mondo tanto cattivo in cui siamo condannati a vivere. Ritengo la diffusione di queste menzogne il più grave delitto del nostro tempo perché minaccia la gioventù e tenta di sottrarle il suo diritto alla speranza e all'ottimismo. In alcuni casi porta al suicidio, alla droga o al terrorismo.
biografia:
Karl Popper - Vienna 1902 - Londra 1994/Filosofo della scienza e della politica è stato un grande teorico del pensiero liberale. Tra i suoi scritti tradotti in italiano:
Congetture e confutazioni (Bologna 1969)
Logica della scoperta scientifica (Torino 1970)
La società aperta ed i suoi nemici (Roma 1973-1974)
La ricerca non ha fine (Roma 1976)
Verso una teoria evoluzionistica della conoscenza (Roma 1994)
|
|
|
|